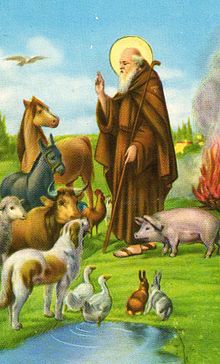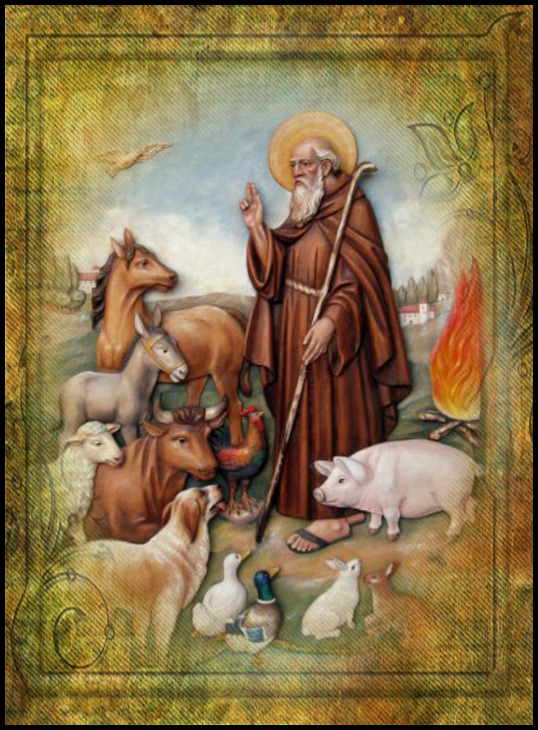Sant'Antonio Abate: l'antica
tradizione nelle terre di fiume
Sempre per la vigilia, un tempo, anche il contadino più miscredente celebrava un rito singolare accendendo un cero di fronte all’immagine del santo nell’edicola a lui dedicata e posta
Torna l’appuntamento con una delle ricorrenze più tradizionali, sentite ed attese della campagna. Quella che, forse più di tutte, lega i territori di pianura di qua e di là dal Po. Si tratta della festa di Sant’Antonio Abate, fondatore del monachesimo cristiano, primo degli abati ma anche uno dei più illustri anacoreti della storia della Chiesa.
Una ricorrenza fatta di una fede antica e popolare ma anche di simboli, leggende e tradizioni, tutte legate al celebre santo protettore degli animali domestici, del bestiame, del lavoro del contadino, del fuoco e delle malattie della pelle. La festa forse più popolare e più antica di quelle celebrate nel cuore della campagna, tra l’Oglio e il Po; una di quelle tradizioni sempre rimaste vive tra le popolazioni delle nostre campagne, ma che certamente meriterebbe di essere ulteriormente valorizzata e promossa, anche come occasione per unire le popolazioni rivierasche del Po. In ogni caso, una giornata sempre molto attesa e sentita nelle nostre campagne; l’occasione per sottolineare, una volta in più, il valore e l’importanza della nostra agricoltura, ma anche quella straordinaria passione e quella speciale cura con cui gli agricoltori seguono i propri allevamenti, l’importanza del loro lavoro che assicura cibo e benessere alla collettività.
Attingendo, a piene mani, fra le tradizioni, è doveroso ricordare che già per la vigilia di questa ricorrenza, e quindi il 16 gennaio, è sempre stata una speciale usanza quella di pulire attentamente la stalla, i pollai, i giacigli e le gabbie degli animali. Una sera, quella della vigilia appunto, in cui è meglio non restare ad ascoltare gli animali perché si dice che parlano tra loro e si confidano i maltrattamenti e le crudeltà degli uomini.
Sono parole arcane, segrete, difficili da comprendere: per questo non vanno ascoltate e gli animali non devono essere disturbati; anche perchè si racconta che nei secoli passati, chi l’ha fatto, sarebbe poi morto.
Sempre per la vigilia, un tempo, anche il contadino più miscredente celebrava un rito singolare accendendo un cero di fronte all’immagine del santo nell’edicola a lui dedicata e posta, abitualmente, sopra l’ingresso principale delle stalle, recitando un rosario seguito da specifiche giaculatorie mediante le quali veniva invocata. Su tutte le famiglie di animali, di grande come di piccola taglia, suino incluso, esistenti nella sua proprietà, una specie di protezione del santo stesso. A lui si chiedeva inoltre di difendere tutti, la casa e le cose, specie il fienile (una delle ragioni per cui, generalmente, nelle immagini del santo compare anche il fuoco). Nel giorno del Santo (17 gennaio) è quindi usanza, in numerose località, benedire gli animali, le stalle e gli allevamenti, oltre al sale e al pane (di cui si ciberanno poi gli animali) durante le cerimonie religiose.
Numerose sono le località in cui i parroci si recano di persona, nelle aziende agricole e negli allevamenti, per impartire la benedizione. Per Sant’Antonio, va ricordato, non si devono uccidere gli animali, e quindi ci si è sempre guardati bene dall’immolare, ad esempio, una gallina o un coniglio. Chi lo ha fatto, sempre secondo la tradizione, avrebbe visto ben presto i propri allevamenti decimati da qualche epidemia.
La sera di Sant’Antonio, popolari, anche in terra lombarda, sono poi i famosi falò propiziatori che vedono mescolarsi tradizione sacra e pagana. I falò simboleggiano la volontà di bruciare il vecchio e il negativo ma, secondo altri usi, anche il gettare tra le fiamme una lista dei desideri da benedire con il fuoco. Un modo anche per celebrare o per “accelerare” la fine dell’inverno. La ricorrenza del celebre asceta è da sempre accompagnata da una serie di riti molto antichi, legati strettamente alla vita contadina, che fanno di Antonio Abate un vero e proprio “santo” del popolo.
E’ notoriamente considerato il protettore contro le epidemie di certe malattie, sia dell’uomo, che degli animali. E’ invocato, in particolare, come protettore del bestiame ma anche per scongiurare gli incendi, e non a caso il suo nome è legato ad una forma di herpes nota come “fuoco di Sant’Antonio” o “fuoco sacro”. Antonio Abate è anche considerato il patrono del fuoco e diversi riti che riguardano la sua figura testimoniano un forte legame con le culture precristiane, soprattutto quella celtica. E’ nota infatti l’importanza che rivestiva presso i Celti il rituale legato al fuoco come elemento beneaugurante.
Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente.
Anche l’imperatore Costantino e i suoi figli, pare, ne cercarono il consiglio. La sua vita è raccontata da un discepolo, sant’Atanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio in tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Concilio di Nicea.
I suoi discepoli tramandarono alla Chiesa la sua sapienza, raccolta in 120 detti e in 20 lettere; nella Lettera 8, Sant’Antonio scrisse ai suoi “Chiedete con cuore sincero quel grande Spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ed esso vi sarà dato”. Nel 561 fu scoperto il suo sepolcro e le reliquie cominciarono un lungo viaggiare nel tempo, da Alessandria a Costantinopoli, fino in Francia nell’XI secolo a Motte-Saint-Didier, dove fu costruita una chiesa in suo onore. In questa chiesa a venerarne le reliquie, affluivano folle di malati, soprattutto di ergotismo canceroso, causato dall’avvelenamento di un fungo presente nella segala, usata per fare il pane. Il morbo era conosciuto sin dall’antichità come “ignis sacer” per il bruciore che provocava; per ospitare tutti gli ammalati che giungevano, si costruì un ospedale e una Confraternita di religiosi, l’antico Ordine ospedaliero degli “Antoniani”; il villaggio prese il nome di Saint-Antoine di Viennois.
Il Papa accordò loro il privilegio di allevare maiali per uso proprio e a spese della comunità, per cui i porcellini potevano circolare liberamente fra cortili e strade, nessuno li toccava se portavano una campanella di riconoscimento. Il loro grasso veniva usato per curare l’ergotismo, che venne chiamato “il male di s. Antonio” e poi “fuoco di s. Antonio” (herpes zoster); per questo nella religiosità popolare, il maiale cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, poi fu considerato il santo patrono dei maiali e per estensione di tutti gli animali domestici e della stalla. Nella sua iconografia compare oltre al maialino con la campanella, anche il bastone degli eremiti a forma di T, la “tau” ultima lettera dell’alfabeto ebraico e quindi allusione alle cose ultime e al destino. Nel giorno della sua festa liturgica, si benedicono le stalle e si portano a benedire gli animali domestici; in alcuni paesi di origine celtica, Sant’Antonio assunse le funzioni della divinità della rinascita e della luce, Lug, il garante di nuova vita, a cui erano consacrati cinghiali e maiali, così s. Antonio venne rappresentato in varie opere d’arte con ai piedi un cinghiale.
Altro aspetto molto importante è la devozione nei confronti del santo per la guarigione de quella dolorosa malattia comunemente nota come “Fuoco di Sant’Antonio”. Una malattia per altro piuttosto comune, così chiamata perchè per la guarigione veniva invocato Sant’Antonio Abate al quale, da sempre, sono riconosciute potenti capacità taumaturgiche. Il cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio è l’herpes zoster, ovvero una malattia virale che interessa la cute e le terminazioni nervose. Lo scatenarsi del fuoco di Sant’Antonio sembra avere come causa la riattivazione del virus della varicella infantile. Quando si viene infettati per la prima volta dal virus, spesso da bambini, si sviluppa la varicella; successivamente il virus permane nell’organismo in uno stato di latenza e può riattivarsi (ad esempio in caso di stress o di eccessiva esposizione al sole) portando allo scatenarsi del Fuoco di Sant’Antonio. Trattandosi dello stesso virus della varicella, è necessario prestare attenzione a non entrare in contatto con soggetti con eruzione da fuoco di Sant’Antonio, soprattutto se si rientra in categorie a rischio come bambini piccoli, donne in gravidanza e pazienti immunodepressi: se non si è già immuni alla varicella (per vaccinazione o per infezione precedente) si rischia di contrarla. Se invece si ha già avuto la varicella o si è stati vaccinati, non c’è pericolo ad entrare in contatto con un soggetto con Fuoco di Sant’Antonio. Nel nome Herpes Zoster si ritrovano parte di quelli che sono i sintomi principali. Le due parole tradotte dal greco significano “serpente” e “cintura” e descrivono appunto quella che è una malattia dolorosa. Il fuoco di Sant’Antonio è paragonabile ad un serpente di fuoco che si annida all’interno del corpo, presenta strascichi lunghi e invalidanti. Si manifesta attraverso una vera e propria eruzione cutanea molto dolorosa fatta di vescicole e nella maggior parte dei casi interessa solo un lato del corpo. Tuttora il celebre asceta è invocato per la guarigione da questa malattia.
Da non dimenticare poi i detti popolari, uno su tutti “Par Sant’Antoni Abà, un’ura sunà”, a significare l’allungamento significativo che le ore di luce hanno ormai subito dalla notte del solstizio del 21 dicembre. Tanti altri sono poi i detti che, da sempre, si tramandano in terra cremonese e casalasca:”Per Sant Antòni se cùr i serióoi se inpiena li bùti e i benasòoi” (Se piove per S. Antonio ci sarà una vendemmia abbondante); “Sant Antòni el fà i póont e San Pàaol el i a ròomp” (Per S. Antonio si fanno i ponti di ghiaccio, ma durano poco: infatti per S. Paolo – 25 gennaio – si scioglieranno); “Per Sant Antòni dèla bàarba biàanca se ghè mìia giàs, la néef ne la màanca” (in questo caso c’è la conferma della rigidità di metà gennaio: se non c’è ghiaccio, certo non manca la neve); “Acqua de fòs, acqua de bìs, Sant Antòni la benedìs” (graziosa e breve preghiera che rivolgevano i contadini assetati che bevevano l’acqua di un fosso: S. Antonio, protettore degli animali, garantiva ad essi che non fosse avvelenata); “Sàant Antòni dèla bàarba bianca, fàme truàa chél che me màanca” (S. Antonio Abate, tra le sue tante doti, era ritenuto capace anche di far trovare le cose smarrite); “Sàant Antòni gluriùus; fìi végner bòon el me murùus che l’è rabìit tama ’n demòni, fème ’sta gràsia, Sàant Antòni” (Altra qualità dell’Abate era quella di far tornare la pace tra gli amanti arrabbiati); “Sàant Antòni chisulèer, el vèen al dersèt de genèer: in che méès végnel?” (indovinello che si faceva ai bambini cercando di confonderli).
Fra tradizione e folclore, fede e cultura, diversi sono gli appuntamenti in programma, in occasione di questa ricorrenza, nelle terre tra l’Oglio e il Po. Domenica, 15 gennaio, a Canneto sull’Oglio si è tenuta la benedizione degli animali, dei trattori e delle macchine agricole. Coldiretti Cremona celebra la festa a Cicognolo, martedì 17 gennaio, con la messa nella chiesa parrocchiale, alle 10.30. Tutti gli agricoltori, e con loro l’intera comunità, sono chiaramente invitati a partecipare. Sempre martedì 17, a Stagno Lombardo, saranno benedetti gli animali e, alle 19, sarà celebrata la messa. Alla stessa ora messa anche a Spinadesco per gli agricoltori e gli allevatori con cena, a seguire, in oratorio. A Casteldidone la messa sarà alle 9 e a San Lorenzo Aroldo alle 17.
Sulla sponda emiliana del Po, ecco che a Vidalenzo, i monaci benedettini “Custodi del Divino Amore” hanno benedetto il sale e il pane domenica 15 gennaio. A Pieveottoville, Ragazzola e Stagno di Roccabianca, lunedì 16 e martedì 17 gennaio, il parroco don Benjamin Ayena benedirà le aziende agricole del territorio mentre martedì 17 gennaio, alle 10, a Pieveottoville, celebrerà la messa nell’oratorio dedicato a Sant’Antonio Abate e, alle 16.30, benedizione degli animali in piazza a Pieveottoville dove, in mattinata, dalle 11.30 alle 13, in oratorio, si potranno trovare anche gli gnocchi aperti (uno dei piatti tipici emiliani più tradizionali di questa occasione, una specialità che davvero merita di essere conosciuta e gustata) ed il ricavato sarà destinato al restauro dell’organo della collegiata.
Diversi gli appuntamenti in programma anche a Busseto e frazioni, martedì 17, con la messa per gli allevatori alle 10.30, in collegiata. Alle 15, sul sagrato della stessa collegiata, benedizione degli animali domestici e, alle 18, messa presieduta dal parroco don Luigi Guglielmoni seguita dalla fiaccolata che raggiungerà la sede del gruppo Alpini Terre del Po dove si terranno la benedizione del fuoco e degli animali. A seguire, vin brulè e gnocchi per tutti a cura del gruppo Alpini Terre del Po. Oltre a quest’ultimo sodalizio partecipano all’organizzazione della giornata il Comune, la parrocchia e le aziende agricole Marco Ronconi di Sant’Andrea; Stefano Ramponi di Frescarolo; la Rinascente di Frescarolo e Il falco pellegrino di Frescarolo. Domenica 15 gennaio, a Busseto, nelle varie messe, è stato benedetto il sale mentre nelle frazioni sarà benedetto domenica 22. Si è detto dei gnocchi aperti, “golosità” tipica della Bassa Parmense.
Ma non vanno dimenticati nemmeno i dolci, come il Biscotto di Sant’Antonio e le Ciambelle a zampa. Quella del Biscotto di Sant’Antonio è tipicamente laziale e si tratta di una preparazione antica già citata nelle “Cronache sulla terra di Acquapendente” del 1588, diffusa in tutto il territorio della Tuscia. Si tratta di un pane dolce profumato all’anice a base di farina, zucchero, uova, latte e olio d’oliva, soffice e solitamente accompagnato con un bicchiere di vino. Viene generalmente impastato a forma di treccia, per sottolineare il forte legame con il Santo, rappresentato dal nodo, simbolo di alleanza e fedeltà. Altro dolce tipico del Lazio, le ciambelle a zampa di Monterotondo, fatte con farina, olio e vino, tre semplici ingredienti che danno vita a biscotti dal sapore rustico e genuino, che devono il loro nome alla forma che, secondo gli abitanti del luogo, ricorda l’impronta lasciata dal bue.
Anche in Emilia si preparano dei biscotti, ma a forma di calzari, fatti con due frolle diverse: una bianca e una al cacao. Quella chiara viene usata per formare la base della ciabatta, mentre con quella scura si prepara il cinturino. Vengono decorati poi a piacere con gocce di cioccolato o glassa. Nel bresciano, Sant’Antonio Abate è conosciuto anche come “mercante della neve”. A lui è dedicato un dolce legato a un’antica superstizione, nata in seguito a una nevicata copiosa che arrivò il giorno del santo di molti secoli fa a minacciare i paesi del Basso Garda. Per evitare il crollo dei tetti sotto il peso della neve, il 17 gennaio le massaie devono infornare il chisol, dolce a base di farina, uova e zucchero:“per sant’Antóne chisöler, chi no fa la turta ghè burla zó ‘l solér”, come recita la filastrocca popolare. in alcune zone della Lombardia (nel Pavese, ma anche a Sant’Angelo Lodigiano) si preparano anche le offelle, biscotti dalla tipica forma ovale fatti da un impasto di ingredienti genuini come farina di frumento, uova, burro, zucchero e olio d’oliva.
Eremita del Po, Paolo Panni